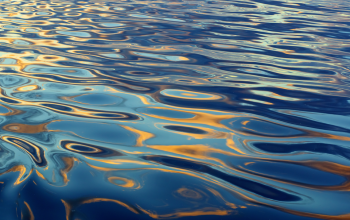Recensione di Acque alte (Cristiano Dorigo, Editore Meligrana, 2024)

Acque alte, di Cristiano Dorigo, Meligrana Editore, 2024, è un romanzo figlio di una scrittura diurna e notturna e, come tale, un’opera completa, un magnum opus.
Il protagonista, per osmosi liquida, amniotica, scambia il proprio ruolo di elemento drammatico principale della storia con il tempo atmosferico e, per contiguità, con l’occhiata che, a Venezia, gli abitanti danno alle nubi, con l’attenzione che essi prestano, dopopranzo, ai laconici avvisi ai naviganti.
Un capriccio della natura – il mare impazzito, destinato a trasformare la città più misteriosa del mondo in un paesaggio dopo la battaglia – è l’ansia esistenziale che si rende realtà palpabile, il ribollire della coscienza che si vocalizza e diviene sirena d’allarme, urlo nella notte diafana.
Con esso – un sovvertimento geologico di dimensioni incommensurabili, annunciato a gran voce dalle radio e dalle televisioni di tutto il mondo – la vita, apparentemente, si paralizza.
Vivere, adesso, è osservazione alla finestra, guerra ad armi impari con la paura e con il senso di morte che, nascosto nelle pieghe della mente, d’un tratto si mostra: eluse le paratie, i sistemi di rinforzo e di protezione, la fine è ormai vicina e veste i panni di un accidente, di ciò che prima o poi, per una nemesi storica, a Venezia, tutti lo sappiamo, dovrà accadere.
Chi di Venezia è figlio legittimo, chi è nato da quelle stesse acque che ora, raggiunto il livello di guardia, salgono e scendono e si divertono a giocare a nascondino, conosce, sin da bambino, queste epifanie: sono momenti di attesa dell’inevitabile, sospensioni della vita, del pensiero.
Ma, in laguna, esiste una forza simbiotica ctonia, sotterranea. Essa confonde le persone con gli elementi naturali che le circondano, siano essi l’alta marea o un refolo salato, un banco di sabbia; questa energia li impasta, li rende un’unica materia vivente. Appartiene alla Natura, questa forza, ma si concede, a tratti, agli uomini di quella terra; permette loro, nonostante la gravità del fenomeno in arrivo – che, nella narrazione, assume un valore cosmico, extraterritoriale – di trasformarsi in liquido vitale, primordiale, in legno secolare smangiato dal sale e capace di rigenerarsi
In quell’acqua, osservata con timore da una finestra elevata a quinta teatrale e gravida di ricordi infantili, di evocazioni familiari, ci si specchia, ora, e ci si osserva; ci si riconosce, riuscendo a raggiungere una dimensione meditativa, contemplativa.
Ed emergono, così facendo, tutti gli strati di questo limo che semina vita e ricordi, che avanza e si ritrae in un movimento ciclico, esistenziale. Ora, dialogando con l’attesa – divenuta non un tempo cronologico ma noi stessi, una sorta di Kairòs che a noi si concede e si fa percorrere a ritroso con dolcezza – e riflettendo su tutto ciò che siamo stati, sulle persone che abbiamo amate, aiutate e desiderate, il dramma della marea assume un connotato esistenziale e si palesa, diventa visibile e dà voce a noi stessi: siamo noi, ora, quella tragedia.
Noi e tutti coloro che abbiamo incontrato, conosciuto.
L’attesa, che ieri ci dominava consumandoci il cuore, che era, all’alba, l’ora infinita che precede la morte, adesso, affacciati al canale colmo, non è solo arresa di fronte all’oblio ma diviene un tempo identico all’altro, a quello da vivere, da esplorare.
L’inevitabile – l’acqua alta che non si ferma, quella che ci hanno annunciato – si trasforma in noi stessi, in ciò che non siamo stati e non saremo mai; in ciò che, come una mancata promessa di narrazione, avevamo giurato di fare, di dare, di costruire senza, ahimè, riuscirci. È, l’acqua alta, l’eco profonda delle nostre illusioni, dei nostri sogni.
Siamo noi, quella catastrofe annunciata. L’abbiamo percepita, ascoltata alla radio e, come spesso accade, creduta. L’abbiamo prima allontanata dai nostri pensieri, poi fatta entrare e, infine, accolta con ritrosia, come accade quando ci guardiamo allo specchio, con il pudore, sul volto, generato dal riconoscimento forzato, imposto. Essa, come la vita, possiede un proprio motore propulsivo, un’energia lunare che ci vede incapaci di intervenire. Ed ha, come ogni elemento vitale, una voce. Quella della nostra infanzia, dei nostri cari. Delle ragazze che, ogni giorno, da trent’anni, assistiamo in una comunità protetta e che, come un calendario di primavera, ciascuna con il proprio nome, quello di un fiore, hanno cadenzato questa prigionia liquida, questi giorni di lontananza dal mondo.
Noi; noi e Amaryllis, Bucaneve, Dalia, Genziana, Lavanda, Margherita, Primula, Ninfea; noi e tutti gli altri fiori del giardino, noi tutti, ora, siamo l’Acqua Alta.
Siamo la sirena, lo sciabordio inquietante, l’odore salmastro che divora ogni cosa.
Cristiano Dorigo, con l’abilità veneziana di sottrarsi all’erosione del tempo – che è sale, abisso, fiotto d’acqua – ha dato voce al cosmo marino, all’urlo del gigante geologico che riposa sotto la sua città, sotto noi tutti. È, quella voce, umana, corale. È un richiamo polifonico alla vita, al tempo dolce: ci giunge come la voce dei fiori sull’acqua, capaci di resistere alle intemperanze del cosmo.
scritto da:
A quarant’anni lascia la professione medica e si trasferisce in Sudafrica, dove vive. Ha scritto la guida Cape Town (Polaris 2016), i romanzi Oltre la vita felice (Polaris, 2017), La jacaranda fiorita (Il Seme Bianco 2017), L’intensità della luce (Emersioni, 2018), Los Angeles, paradise (Emersioni 2019), Rego Park (Castelvecchi, 2021), Liturgia delle pianure (ReadAction Editore, 2023), Il sogno assassino (Castelvecchi, 2024).